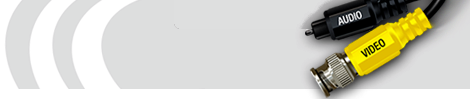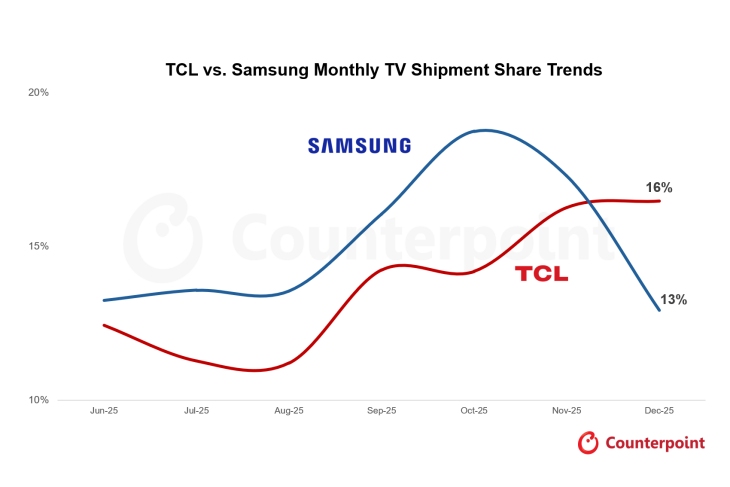1917
Candidato a 10 premi Oscar, arriva nelle sale italiane il nuovo film di Sam Mendes, ambientato nella Francia settentrionale durante la Prima Guerra Mondiale. Un film girato come unico piano sequenza, per un'esperienza visiva da non perdere
Regia e fotografia
1917 è presentato sul grande schermo con lunghissimi piani sequenza. I 119 minuti scorrono però senza stacchi di montaggio evidenti, simulando un’unica ripresa ininterrotta per tutta la durata con sapienti stratagemmi per raccordare, in maniera astuta, quelli che di fatto sono in realtà diversi ciak.
Nell’analisi della pellicola, partiamo proprio dall’uso del piano sequenza, visto che nel bene e nel male è la scelta che condiziona il nostro giudizio sul film.
Tecnica utilizzata in passato sia per interi film (il Nodo alla gola di Alfred Hitchcock prevedeva in tutto solo 10 sequenze, necessarie più che altro per limiti tecnici) o che per piccole parti (L'infernale Quinlan di Orson Welles e Una giornata particolare di Ettore Scola sono gli esempi probabilmente più complessi), il piano sequenza è stato utilizzato sia come mero esercizio tecnico – coadiuvato dai passi avanti della tecnologia (nell’ordine Arca russa, Gravity, Birdman) – sia per strizzare l’occhio a visioni goliardiche (da questo punto di vista il massimo esempio sono probabilmente le sequenze di Hardcore!).
Mendes non era nuovo sia ai film di guerra – vedi Jarhead nel 2005 – che alle sequenze senza montaggio, dopo la palestra della scena di apertura in Spectre ambientata a Città del Messico per il Giorno dei Morti.
In 1917 la scelta di girare tutto il film in piano sequenza aveva lo scopo di avvicinare lo spettatore ai due protagonisti, non perderli mai di vista e sentire costantemente i loro passi, il loro respiro e la loro prospettiva. Una scelta che, di fatto, è la preferenza attorno alla quale è stato costruito l’intero film, con tutti gli aspetti e i reparti al servizio di questa opzione stilistica.
Effettivamente la scelta è vincente, ben progettata e sviluppata tecnicamente in maniera eccellente. Lo si intuisce già dalla sequenza di apertura, con un ingresso in trincea che accompagna lo spettatore letteralmente nelle terre di Francia, a stretto contatto con i soldati e i protagonisti dell’epoca.
La macchina da presa comincia così a seguire e precedere gli attori, con un infinito walzer che attraverso riuscite trovate registiche, non è mai monotono o noioso, scegliendo improvvisamente di seguire con una carrellata laterale i protagonisti – bellissimo in questo senso anche l’utilizzo dell’altezza dal suolo come diversivo – o con i più ampi movimenti di dolly o le più intime situazioni gestite con steadycam.
A volte la macchina viene agganciata a un a un cavo e trasportata da un cameraman, per poi essere liberata e portata da un altro operatore a bordo di una jeep per percorrere qualche centinaio di metri, scendere, essere liberata ed affidata a un terzo operatore per il proseguo della scena.
L’utilizzo del piano sequenza ha vincolato anche il passare del tempo, che scorre praticamente in tempo reale (in questo senso siamo all’opposto ad esempio con Dunkirk) nelle quasi due ore di durata, ad esclusione di un salto – necessario per cambiare la luce del set – orchestrato in maniera impeccabile a livello di script. Salto temporale che, tra l’altro, anticipa una delle sequenza visivamente più spettacolari dell’intero film.
Merito di tutto questo, oltre che del regista, è anche dell’immenso direttore della fotografia Roger Deakins (insieme a Mendes già in Jarhead, Revolutionary Road e Skyfall ma che ricordiamo anche per Sicario e Blade Runner 2049 con Denis Villeneuve e tanti film con i fratelli Coen), che ha orchestrato, immaginato e seguito nel dettaglio un pazzo progetto, mettendo la sua competenza al servizio di una scelta stilistica che alla fine si è rivelata vincente.
Girato anche in ordine cronologico, per evidenti difficoltà di illuminazione, ombre e luci dovute a un set esplorato a 360 gradi ed estremamente vasto, il team tecnico ha deciso di girare gli esterni unicamente con luce naturale, attendendo sempre momenti di cielo coperto per evitare situazioni gestite in maniera imprevedibile da Madre Natura.
L’unica scena con un utilizzo massiccio di luci artificiali è la già citata miglior sequenza visiva dell’incendio della chiesa, illuminata con un immenso rig alto come un palazzo da 5 piani, formato da 2.000 lampade al tungsteno per una potenza complessiva di 2 megawatt.
Deakins da tempo utilizza le macchine da presa digitali ARRI. Nell’estate del 2018, lui e sua moglie James Ellis (digital workflow consultant del film) sono stati invitati presso la fabbrica ARRI Munich per visionare una versione ridotta della ALEXA LF, utile proprio per il tipo di riprese di 1917. A febbraio 2019 i primi prototipi della ALEXA Mini LF erano pronti, e Deakins e la sua squadra di lavoro hanno subito testato la nuova camera con l’attrezzatura che a breve avrebbero utilizzato per il film: Trinity, Steadicam, StabilEye, DragonFly e Wirecam.
Visto il responso positivo, il filmmaker ha deciso di utilizzare la versione "Mini" nella produzione in partenza, anche perché in fabbrica erano riusciti a conservare il formato "large" (ovvero "full-frame") del sensore originale ALEXA LF (4.5k), con area che vale quasi il doppio (937 mmq, rapporto d'aspetto 1,43:1) rispetto al sensore "Super 35" delle altre camere Arri ALEXA (513 mmq, 3,4K e rapporto d'aspetto 1,55:1), con prestazioni su rumore, sensibilità e gamma dinamica nettamente superiori.