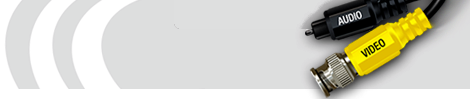State dimenticando l'aspetto fondamentale.
Nyquist-Shannon vale solo in casi ideali, come spiega benissimo la pagina di wikipedia in inglese, che consiglio a tutti di leggere.
Spiega chiaramente come in casi reali, con DAC reali, il campionamento non possa riprodurre l'onda originale, ma una finita approssimazione di essa, che si discosta da essa non solo nelle frequenze non udibili, ma in TUTTE le frequenze, essendo una approssimazione.
La pagina di wikipedia spiega bene il motivo di ciò e i principali problemi.
Campionamenti a più alte frequenze riducono gli errori introdotti dai DAC e quindi avvicinano l'approssimazione all'onda originale.
Quale sia la frequenza in HZ, dato il miglior campionatore disponibile oggi, alla quale diventi inudibile la differenza fra onda originale e aprrossimazione, è difficile dirlo.
Io credo che stia in mezzo fra i 48 khz e i 96 khz, per la mia esperienza, potrebbe essere 60, 70 o qualcosa del genere (e quindi a quel punto conviene campionare a 96).
Inoltre e' stato provato più volte che ci sono dei fenomeni di colorazione del suono dati dall'interazione di onde supersoniche (sono detti fenomeni di intermodulazione supersonica) di vari strumenti, che causa che il suono in area udibile venga alterato.
Per cui se i vari strumenti sono registrati da vicino separatamente, il suono raggiunge il microfono prima che interagisca con le altre onde e quindi questa colorazione non viene registrata e quindi bisogna fare in modo che venga riprodotta in ambiente di ascolto, per avere un effetto identico all'originale.
Invece è inutile se registriamo con un unico microfono a distanza di qualche metro: a quel punto il fenomeno di colorazione è gia avvenuto, e la sua parte udibile è stata registrata, quindi le frequenze inudibili non servono più ad una bega, ma non è questo di solito il caso delle registrazioni moderne, dove vengono registrati separatamente da molto vicino i vari strumenti, e poi mixati in maniera asettica e digitale (senza colorazione o interazioni fra le forme d'onda quindi) nel nostro CD/SACD/etc...
Quindi se anche io non potessi sentire 20khz o 25 khz del tutto e se anche i miei diffusori avessero un forte attenuamento sopra i 16-20 khz, registrare le alte frequenze servirebbe a far emettere ai diffusori le onde supersoniche che riprodotte insieme in ambiente interagirebbero tra di loro, causando un 'coloramento' del suono nella parte udibile (20hz-10khz).
Morale, ci sono questi punti fermi PROVATI E RIPORTATI DA WIKIPEDIA STESSA:
A) Un qualunque DAC reale con una qualunque onda reale e complessa, viola il principio di Nyquist-Shannon. E' fisicamente impossibile costruire un DAC che operi su un'onda reale e ne dia una perfetta rappresentazione, a tutte le frequenze. C'è sempre una approssimazione della forma d'onda e questa approssimazione è tanto piu precisa quanto è piu alta la frequenza di campionamento, senza essere MAI perfetta (neanche a 100000000000000000000000000000 khz di campionamento)
B) L'intermodulazione supersonica fa in modo che contino anche le frequenze non udibili, finchè sono riproducibili, con un volume anche attenuato, dal nostro impianto, per 'colorare' la parte udibile.
Queste due cose insieme provano che e' necessario, in un'ottica di alta fedeltà, una frequenza di campionamento più alta.
Se poi la differenza fra i 48 e i 96 sia udibile o meno, non tocca a me dirlo, fate una prova voi stessi. Io l'ho fatta e mi sembra di sentirla, ma non ho mai fatto un test in doppio cieco riguardo questo, quindi no mi fido.
Per me quanto 'sia giusto' per avere l'ottimo è difficile da dirlo, IMHO come detto sta in mezzo fra 48 e 96, quindi vorrei sempre campionamenti a 96 khz, per non rischiare.
E' stato quindi PROVATO che non e' assolutamente vero che campionare a 96 khz è inutile: anzi è molto utile per avere una approssimazione sonora più vicina alla realtà di un ascolto live della musica (forme d'onda più vicine alle originali, colorazioni, etc...).
Il discorso è quale è la soglia dell'udibilità di questa differenza: se sotto i 48 khz, se fra i 48 e i 96, se fra i 96 e i 192.
Io propendo come detto per 48/96

MA LA DIFFERENZA C'E', e a TUTTE le frequenze di emissione, non solo nelle altissime, punto.